«La guerra non è fatta di atti eroici. È fatta di errori, scomodità e di gente che ha paura e continua lo stesso.»
Nel panorama dei libri sulla Resistenza, I piccoli maestri di Luigi Meneghello è un urlo gentile. Non grida “eroi!”, non indossa divise ben stirate, non ha la postura muscolare del patriota da social. È un libro fatto di carne, di imprecisioni, di ragazzi poco adatti alla guerra eppure determinati a non stare dalla parte sbagliata della Storia.
Luigi Meneghello, classe 1922, professore e linguista, antifascista per vocazione morale più che per ideologia, scrive il suo libro nel 1964, vent’anni dopo essere salito in montagna con un gruppo di amici-studenti. Non erano partigiani professionisti, non erano soldati. Erano — come suggerisce il titolo — piccoli maestri. Educati, idealisti, confusi. E per questo potentissimi.
Quello che rende questo romanzo-memoria diverso da tutti gli altri è il tono: Meneghello racconta la guerra partigiana senza glorificarla. Ci sono gli errori di mira, le discussioni inutili, la fame, la neve, le scelte sbagliate. Ma anche le scelte giuste, fatte nel momento peggiore. La Resistenza, qui, non è un monumento: è una fatica. Un atto umano, non una favola. Ed è proprio per questo che diventa grandiosa (più vera).
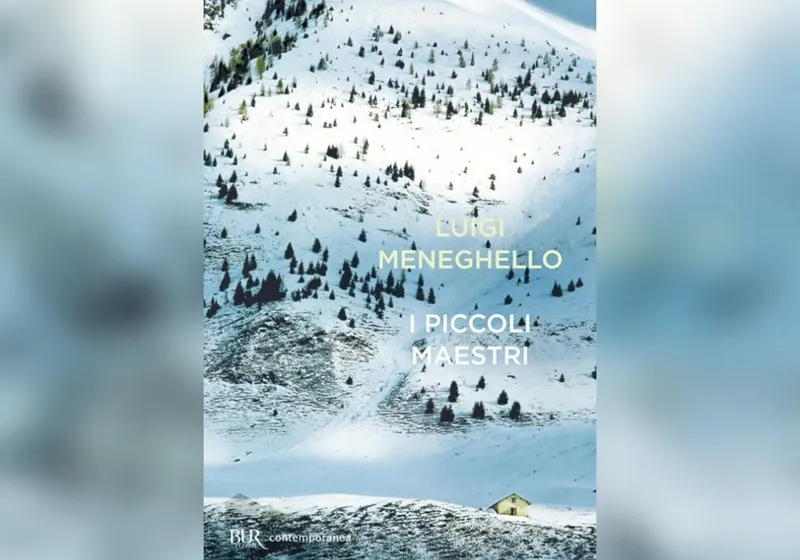
La lingua è secca, precisa, tagliente come la lama di un temperino. Meneghello sa che l’ironia è l’arma più letale contro il potere. D’altronde il fascismo, prima di essere un regime, era proprio questo: un potere grottesco, arrogante, che odiava il pensiero complesso, la sfumatura, la battuta intelligente. I fascisti non sapevano o forse non dovevano ridere. Meneghello sì. E colpisce così.
Non c’è retorica nei Piccoli maestri. Solo verità. E umiltà. Ecco un esempio:
“Scommetto che avete fatto gli atti di valore.”
“Macché atti di valore. Non eravamo mica buoni, a fare la guerra.”
Il romanzo si svolge sui Colli Berici e sull’Altopiano di Asiago, zone che oggi odorano di escursioni e cicloturismo, ma che allora erano teatro di imboscate, rastrellamenti e dilemmi etici. Cosa si fa quando il nemico ha un volto familiare? Quando si scopre che anche gli amici possono diventare delatori? Quando la guerra è confusa, e non c’è un generale che ti dice dove sparare?
Leggere I piccoli maestri oggi è come accendere una luce su quello che siamo stati e che rischiamo di dimenticare. In un’Italia dove si fa finta che il fascismo non torni perché “non è più come una volta”, dove chi urla “Boia chi molla!” o “Presente!” è ormai sdoganato alla stregua di chi manifesta le proprie idee (e no, il fascismo non è un pensiero, è la morte di ogni libertà), questo libro è un vaccino. Uno di quelli veri. Antifascista. Umanista. Ironico.
Per questo lo leggiamo. Per questo lo amiamo. Perché ci ricorda che anche chi non era nato per combattere, ha avuto il coraggio di disobbedire. E non è detto che non succederà di nuovo.
Farlo oggi, caro lettore, è ancora un atto di resistenza civile.
